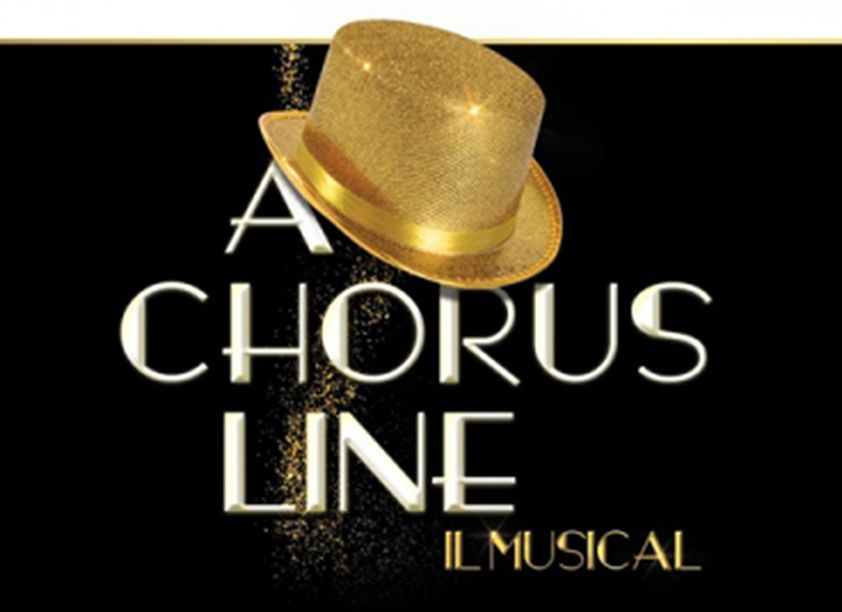Echo And The Bunnymen @ Percuotere_la_mente
• Echo and the Bunnymen •
Corte degli Agostiniani (Rimini) // 08 Luglio 2019
Perché gli anni Ottanta non smettono di tornare? Questa domanda mi gira in testa da un po’ e continua a ripetersi anche mentre aspetto che Echo and the Bunnymen salgano sul palco della Corte degli Agostiniani, a Rimini, in occasione della rassegna musicale Percuotere la Mente.
Il gruppo ha avuto un discreto successo tra il 1978 e per tutto il decennio successivo, con lembi di notorietà arrivati fino ai giorni nostri.
Qualcuno li avrà scoperti grazie ad una recente cover di Manuel Agnelli nel suo programma televisivo “Ossigeno”, altri invece se li ricorderanno per la presenza di uno dei loro pezzi più celebri, The Killing Moon, nella colonna sonora nel film culto Donnie Darko, altri ancora, quelli che negli anni Ottanta avevano vent’anni, perché sono stati uno dei gruppi più promettenti della scena inglese.
Nella serata dell’8 Luglio, a Rimini, hanno riempito l’arena estiva e dato vita ad uno spettacolo godibile, anche – e soprattutto – per l’ebrezza, vera o presunta non importa, di McCulloch. Il frontman del gruppo si colloca a metà strada tra Lou Reed e Jim Morrison.
E infatti, nella scaletta non mancano una cover di Roadhouse Blues dei Doors e un accenno sfumato di Walk on the Wild Side. A onore della cronaca, bisogna dire che Ian McCulloch non dimostra affatto gli anni che l’anagrafe gli attesta.
Il pubblico presente invece è variegato: ci sono i fan di prima generazione, ma non mancano nemmeno quelli come me, curiosi o appassionati della musica inglese di quegli anni, che hanno formato i propri gusti musicali a suon di Joy Division, Siouxsie and the Banshees o Bauhaus.
La band arriva da Liverpool, e della formazione originale rimangono solo due elementi: Ian McCulloch e Will Sergeant. Gli altri membri del gruppo presenti sul palco avranno trent’anni, più o meno.
Quindi, per quale motivo, così tante persone si stringono sotto il palco a cantare le loro canzoni, nonostante da tempo non esca qualcosa di nuovo? L’ultimo loro disco risale al 2014 e non ha fatto di certo gridare al miracolo e non può essere sufficiente il fatto che quella di Rimini sia l’unica data italiana.
Allora è vero che gli anni Ottanta stanno tornando? Probabilmente no. La mia sensazione è che il problema non siano tanto gli Ottanta, quanto il presente. Nessun periodo storico è stato così ossessionato dal passato come questo.
Stiamo vivendo una sorta di “retromania”, termine utilizzato Simon Reynolds per definire quell’innamoramento totale e assoluto per un passato più o meno recente. E proprio il fatto che si tratti di un passato recente, non reinventabile e che non lascia spazio a riscritture, è curioso.
Questo culto degli anni Ottanta, che si può trovare nella musica – Echo and the Bunnymen sono solo un esempio, il meno convenzionale, senza bisogno di scomodare altri gruppi ben più famosi e ingombranti – così come nelle serie TV, è legato alle nostre ossessioni.
Non è un caso che Stranger Things sia quello che di più vicino all’immaginario pop americano degli anni Ottanta si sia visto dai tempi di Donnie Darko. Quel periodo è stato l’età dell’oro, del benessere, ma anche l’inizio del declino. Oggi non esiste uno stile musicale così rappresentativo, come lo sia stato la new wave o il post punk, per gli anni Ottanta. La trap, forse?
La verità è che le tendenze scivolano veloci tra le dita e prima che possiamo accorgercene sono già state sostituite da qualcosa di nuovo. La realtà in cui viviamo è affollata di stili e noi, in tutta risposta, ci rifugiamo in questo passato recente di cui ancora possiamo avere memoria.
Gli ultimi tempi prima di Internet, l’ultimo decennio prima dell’invasione dell’informatica e della rete. Tutto era controllabile, gestibile, sicuro. Un piccolo Paradiso Terrestre, anche per quanto riguarda la produzione musicale.
La sensazione che ho, riguardo a questa retromania, è che rallenti ulteriormente l’arrivo di un “futuro” non meglio precisato: Lady Gaga si è ispirata a Madonna, Amy Winehouse ha ripreso gli stilemi del soul anni Sessanta, i nuovi indie indossano le magliette dei Joy Division. Mentre rimango in attesa di una tabula rasa per superare finalmente questi maledetti anni Ottanta, Echo and the Bunnyman partono subito con le grandi hit.
McCulloch e compagni hanno vissuto sulla propria pelle il post-punk e la new wave, ma solo con The Killing Moon hanno ottenuto il successo che meritavano. Per anni si sono occupati di alcuni progetti solisti fino a che non è arrivata l’inevitabile reunion. Così sono tornati, acclamati da una nuova generazione di discepoli.
Gli ultimi scampoli della loro carriera possono essere imputati alla retromania, anche se gli ultimi dischi, quelli degli anni Duemila, pur senza aggiungere niente di nuovo alla loro storia, sono comunque apprezzati dai fan. Per provare a spiegare l’affetto che il pubblico gli riserva, bisogna tirare in ballo anche la personalità di McCulloch: istrione, sopra le righe e carismatico.
Occhiali da sole anche di notte e giacca di pelle con 35°C, insieme alla sigaretta in bocca è la divisa di ordinanza, manco a dirlo, degli anni Ottanta. Quando arriva il momento, The Killing Moon fa inumidire gli occhi anche dei più insensibili. McCulloch può mostrare i muscoli o deprimersi ma risulta sempre perfetto per incarnare e raccontare la complessità di un gruppo come Echo and The Bunnymen.
Dopo le prime canzoni McCulloch fa alzare il pubblico, come si conviene a un concerto come questo, chiamandolo sotto al palco. Il quadro viene completato dal tocco decisivo, che non può mancare per completare l’affresco: l’uso dei sintetizzatori.
Quello che manca, forse, è un po’ di coraggio. Non sono i Depeche Mode che continuano a sfornare nuovo materiale, Echo and the Bunnymen stanno guardando al passato. Loro avevano le canzoni, la chitarra spettrale di Will Seargent, la sezione ritmica che funzionava come una macchina e avevano Ian McCulloch, che riusciva a camminare sul filo del rasoio, tra il punk e la poesia.
Decenni dopo sono ancora qui, in questo luogo misterioso e pieno di fan in visibilio.
Daniela Fabbri