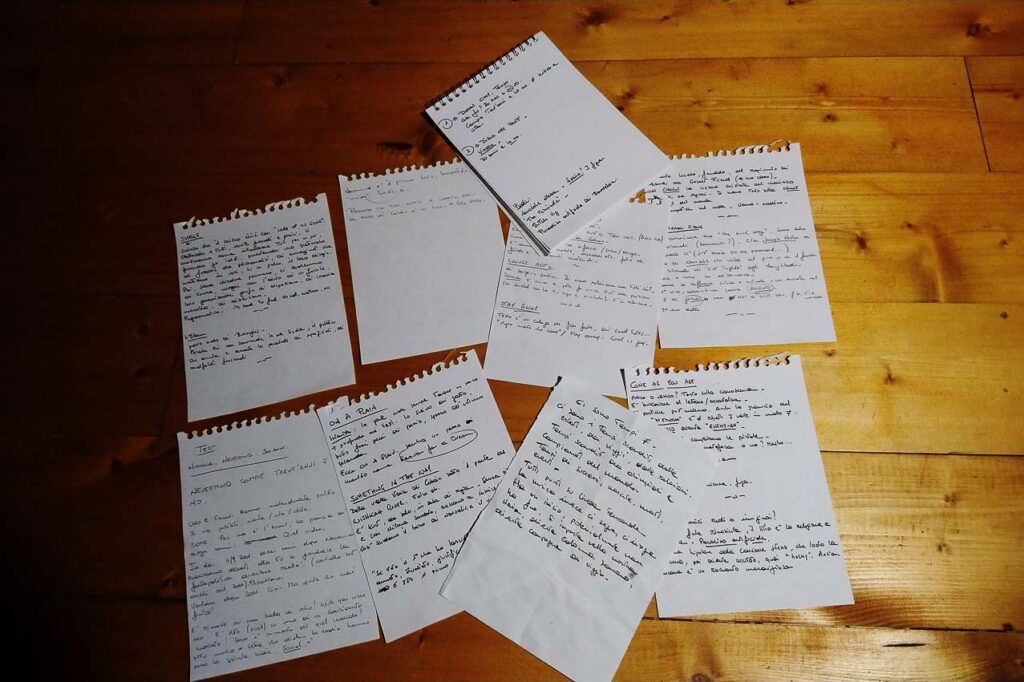Nevermind compie trent’anni e io no
Si è preso il pomeriggio libero. E una bottiglia di buon vino.
Telefono spento, non capitava da secoli. Doccia, vestiti puliti, quasi fosse un appuntamento. Arrivando al mobile del giradischi ha un’esitazione. Prende in mano il disco, osserva la copertina a lungo.
Due soli pensieri lo sfiorano: il primo riguarda la sua personale opinione del soggetto immortalato, dopo la richiesta di risarcimento. E pace, esiste il karma, ne è convinto. Il secondo è che quel pezzo di cartone, quel bambino che nuota è il suo personale ritratto di Dorian Gray. Anzi, che lui stesso è, per quel disco, il quadro che invecchia. Quel fottuto bambino rimarrà per sempre piccolo, nudo e con pistolino notevole. Quel disco rimarrà per sempre giovane. Per sempre meraviglioso. Per sempre adorato. Lui invece no, invecchierà, diventerà noioso, conservatore e malinconico. Il disco si nutrirà di lui, perché il patto è stato sancito nel 1991 e mai verrà spezzato. Non c’è un solo disco che lui abbia amato che di colpo sia invecchiato male. O che proprio sia invecchiato.
È il dono che la musica porta con sé, è il modo che la musica ha per fregare il tempo. Perché ci sono tempi scanditi dalle estati, dai viaggi, dalle relazioni, tempi scanditi da olimpiadi, nascite, morti e successi. Ma sono tutti punti sulla linea temporale.
La musica invece ci segue, a volte ci insegue. La nostra relazione con i dischi che amiamo ha un inizio, raramente una fine, perché si impasta con la nostra vita, si intreccia nella storia, diventa colonna sonora, diventa compagna. A volte è un accento, a volte medicina.
Lui aveva da poco fatto le analisi per colesterolo e tristezza, le principali candidate del suo malessere. Dieta e musica. Nessuno aveva contemplato il vino, ergo, fanculo.
 Nevermind compie trent’anni. E lui no. Lui ne ha compiuti di più. Però Nevermind e lui hanno compiuto trent’anni, quindi è il caso di festeggiare come si deve.
Nevermind compie trent’anni. E lui no. Lui ne ha compiuti di più. Però Nevermind e lui hanno compiuto trent’anni, quindi è il caso di festeggiare come si deve.
Si siede per terra, si accende una sigaretta, il fruscio della sigaretta si confonde con quello della puntina. E allora cuffie su, il mondo resti fuori, questa è una cosa tra lui e i Nirvana.
Quattro accordi, che sono un portale per l’inizio di tutto. L’alfa degli anni novanta, il big bang, forse involontario o forse no, che cambiò le regole del gioco. Una overture che puzzava di icona generazionale dopo soli cinque secondi. Poi Novoselic riportava la calma, poco prima che Kurt chiamasse tutti alle armi. Letteralmente.
“Venite siore e siori, venite grandi e piccini. Vi mostreremo come intrattenere tutti quanti per quasi quarantacinque minuti! Uno spettacolo di freaks da psicoanalisi, un trio di emarginati che mettono in versi, su un palco, il loro personal disagio! Rimarrete incantati da golosissimi riff e ritornelli orecchiabili, e nel mentre faremo passare testi pesantissimi, senza che nessuno sanguini dalle orecchie! Intanto caricate i fucili, si sa mai!”.
Benvenuti nella palestra più famosa della storia della musica. Potere di MTV, potere di una generazione pronta a smontare le permanenti di molte band. L’onda lunga degli anni ottanta sbatteva contro tre ragazzi armati di rabbia, intelligenza, sensibilità e una discreta dipendenza dagli oppioidi.
La depressione, la disillusione, una geniale ironia a tratti macabra. Smell Like Teen Spirits era programmatico, era il manifesto di un disco, di un pensiero, di un inizio.
(Scivola la puntina, scivola giù altro vino.)
Kurt gioca con Burroughs, e poi fa cantare tutti i fans dell’ultima ora, perfetti analfabeti funzionali, un ritornello che descrive la follia collettiva che li sta per investire. In Bloom. Sì, però.
Però è la seconda canzone in cui si parla di armi, Kurt.
Però questa non è solo ironia. Qua si parla di incomunicabilità. “I like beautiful melodies telling me terrible things”, diceva Tom Waits. Sembra la terza legge incisa a scalpello sulle tavole del grunge.
Come as You Are continua sulla stessa ambiguità, sulle sfocature, in una canzone dove le parole scivolano una dentro l’altra, dove il nemico diventa memoria, dove aprirsi all’altro è una continua scommessa, dove essere disarmati è l’unica condizione per la conoscenza.
(Vino. Serve vino.)
Paura, depressione, fuga di Breed. Si cade poi nel paradiso artificiale di Lithium, dove è bipolare la struttura della canzone, che diventa lei stessa messaggio, facendo per un attimo comparire McLuhan sopra la puntina. No, sarà il vino. Però la canzone-è-il-messaggio, poche storie.
Polly rovescia i punti di vista, è come se a metà di una partita a scacchi vi scambiaste le parti. È un esercizio di stile, ma di nuovo è anche una domanda profonda sulla comprensione e sulla visione della realtà. Si passa a Heller, al Comma 22 , nelle terre tiratissime di Territorial Pissing, tre accordi in 2:22 per un crescendo di alienazione, di differenze, di urla disperate, mentre Grohl maltratta definitivamente la batteria e il “The Terminator”, il rullante comprato apposta per Nevermind dal suono quantomeno incisivo.
Si passa ai sentimenti, all’amor scortese, quello per Tobi Veil, anche se Drain You fa un po’ di confusione tra infanzia, sesso e droga. Tra fluidi corporei e sostanze stupefacenti, tra dipendenze e interscambi. O forse è tutto voluto, sepolto solo da un velo di buoni accordi per celare il significato ai più?
Stay Away è un collage di frasi fatte, è inno alla superficialità. Il puzzle di Nevermind è quasi completo. Serve il non-sense di On a Plain, perché Kurt lo dirà, anni dopo: era pigro, spesso scriveva i testi all’ultimo e non sempre questi avevano un senso vero e proprio. “Impressionismo cazzaro”, fu definito da critico anonimo. A volte uscivano grandi cose, a volte materiale buono per la psicoanalisi, a volte solo parole.
(Sono veramente ubriaco)

Something in The Way ha dentro l’essenza di Nevermind. In studio proprio non veniva. Butch Vig, che durante le registrazioni rubava i takes a Kurt con ogni mezzo possibile, si accorge che il cantante stava finalmente suonando da dio, ma era in sala di regia, con la chitarra scordata e senza qualcuno che gli desse il ritmo. Ma era buona, vera e unica. Prese Novoselic e scordò il basso. E seguì il violoncello.
Nevermind era questo.
Kurt urla ancora per qualche minuto nella ghost track.
Poi la puntina esce dal solco.
Silenzio, un bicchiere vuoto, un sospiro.
Nevermind è stato il primo che “ho lasciato entrare”. Il primo album che ho amato, studiato, giustificato, idolatrato, tradito.
Nevermind fu il primo bacio. Indimenticabile, umido, direbbe il signor Gump, inaspettato. Sperato.
È il mio Dorian Gray, sarà sempre lì, identico e monolitico nella sua grandezza.
Nevermind compie trent’anni. E io no. Loro sono diventati una pagina nera sul diario del liceo. Otto aprile, data dell’annuncio. Lasciarono un groviglio indistricabile di domande, un peso infinito nella testa di un adolescente. Fu un dolore fisico, che ricordo bene. La loro fine e la loro storia successiva sembrarono le risposte alle domande di Nevermind. Tre vie, tre possibili bivi da prendere, tre modi di affrontare la vita. Servono gli anni in più che ho per accettare il fatto che il lieto fine non è tanto rock.
Ma questo album servì a iniziare qualcosa. Servì per aprirsi a una nuova musica, a nuovi anni, a trovare nei Pearl Jam il mio “bright side” del grunge e innamorarmi di nuovo, servì per i dischi, i concerti, la musica.
Servì per parlare con nuove persone, con amici che resistono, servì a condividere, a ballarci su e a viaggiare cantando. Servì riascoltarlo dieci anni dopo, vent’anni dopo e vedere dove cazzo stavo andando. Serve riascoltarlo anche a distanza di trent’anni e sentire che gusto ha.
Nevermind compie trent’anni. Io molti di più, ma stiamo ancora bene insieme.
Senza arrossire, sono fortunato.
Oh well, wathever,
Nevermind.
Andrea Riscossa