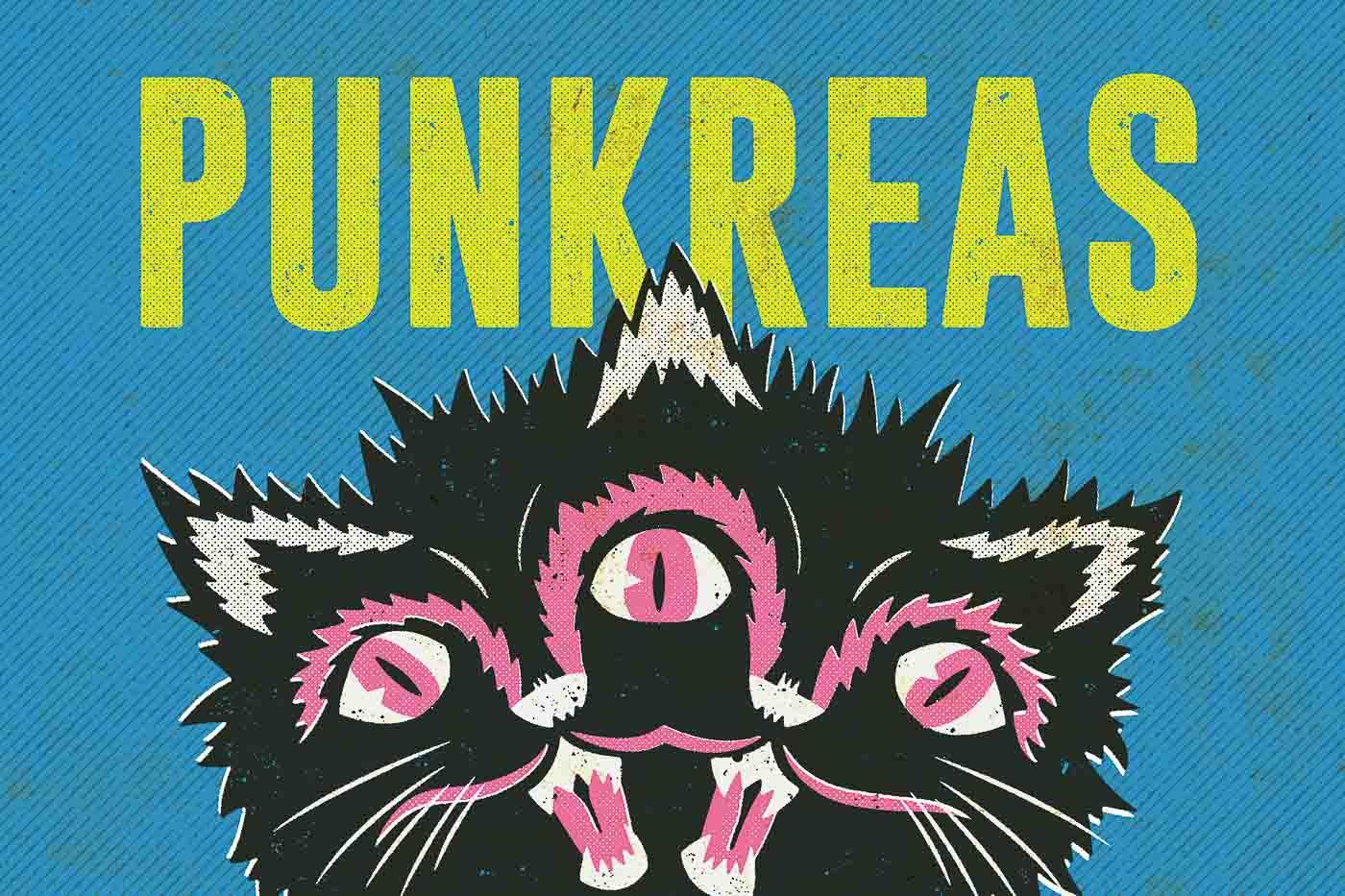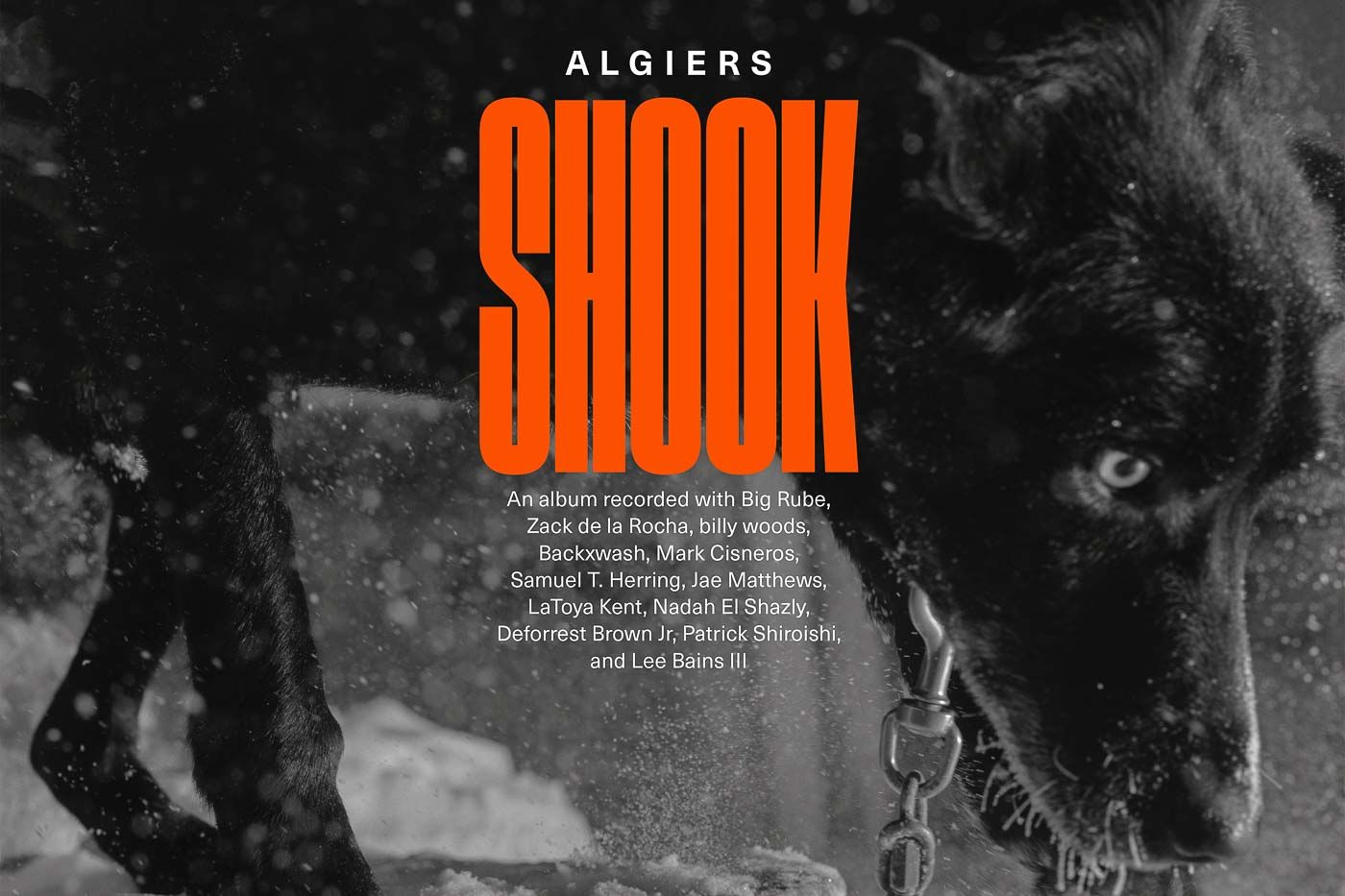Atum: A Rock Opera in Three Acts
Act Three: l’atto di fede.
Premetto che questa recensione sarà atipica rispetto a una di quelle con una struttura canonica, perché non c’è più molta necessità di presentare il gruppo né il progetto (leggi qui le recensioni di Act One e Act Two, NdR). Gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato l’atto finale di un’opera quantomai attesa e discussa. Come il secondo atto ha avuto il sapore dolce amaro di L’amore ai tempi del colera, l’ultima parte di Atum: A Rock Opera in Three Acts non può fare altro che richiamare alla mia un’altra opera di Gabriel Garcia Marquez: Cronaca di una morte annunciata. L’associazione non riguarda i contenuti, quanto l’impressione che il terzo atto ricorda più il sospiro agonizzante di Santiago Nazar che non il seguito dei rimpianti Mellon Collie e Machina.
Ascoltare la conclusione di un progetto così ampio e coccolato dal suo creatore dovrebbe essere un momento di magica estasi per l’ascoltatore. Eppure, questo momento tanto aspettato, cercato, voluto non arriva mai. A partire dall’apertura con Sojourner fino a Of Wings si passa da brani come Pacer, Harmageddon e Cenotaph dove il titolo rimane più impresso della musica stessa. Si possono incontrare delle chitarre distorte in qua e là, dei violini, synth, strumenti che trasmettono solo l’idea di un lungo lamento. La sensazione è che la musica non esploda mai, che l’emozione non decolli, anzi che venga proprio schiacciata da qualcosa che non riesce a librarsi nelle note. L’atto è impregnato di un desiderio incompiuto, senza la vibrante sensazione che il desiderio stesso dà. Le canzoni sono sempre lì, sulla linea di partenza, e se questo poteva essere accettabile, anche se non scusabile, nel primo atto, nel terzo no, non lo è, mentre la voce di Corgan non basta più a lenire il dolore per un amore che si è rotto, anzi diventa a tratti fastidiosa perché butta solo sale su una ferita ormai aperta. Se poi queste undici tracce si ascoltano nell’insieme del progetto completo, la delusione aumenta, e l’affetto per chi ti ha regalato un’adolescenza piena di momenti che ancora senti sulla pelle è inutile. Possiamo dire che ci sono degli spunti qui, o in questa canzone là, oppure in quel passaggio dove la chitarra elettrica emerge, e così via. Io aggiungerei che ci mancherebbe altro che qualcosa non sappiano fare, perché queste osservazioni vanno bene per chi non ha esperienza e fa i primi passi, non per chi ha un posto importante nel panorama musicale. Ascoltando tutto il progetto ti chiedi, però, se forse le tue aspettative non sono troppo alte, se non riesci più a capirli e quella frequenza che loro avevano trovato con altri progetti ora non esiste più dentro di te. Tuttavia, quando ascoltare è più un atto di fede che non un piacere, allora qualcosa non va. Realizzi che l’affetto nato dalla nostalgia di un tempo che fu non basta, che il tempo è passato e non solo per te, che il tiro va aggiustato.
Atum: A Rock Opera in Three Acts – Act III va ascoltato per realizzare che niente è per sempre, perché la vena creativa può esaurirsi come l’oro del Klondike, le storie di Happy Days, le gomme da masticare preferite al bar sotto casa. Tuttavia, esaurire questa vena non vuol dire essere destinati a sparire, bensì fare la scelta di Klimt, che quando capì di non poter più dare molto al mondo dell’arte decise di usare la sua fama e il suo intuito per scoprire e promuovere nuove correnti, nuovi artisti. Si può essere sempre presenti e importanti nel mondo che sentiamo nostro, solo che è possibile farlo in altro modo e gli applausi, poi, verranno da soli per ciò che si fa nel presente e non solo per uno sbiadito omaggio a ciò che è stato vivo nel passato.
Smashing Pumpkins
Atum: A Rock Opera in Three Acts
Martha’s Music/Napalm Records
Alma Marlia